Tratto da “Mafia un problema antropologico?” di Filippo Sileci – relatore Prof.ssa Silvia Bianciardi
Capitolo primo
1.1 Mafia: etimologia e significato del termine
Il termine mafia, per quanto possa sembrare strano, è la parola italiana più conosciuta al mondo, ma a dispetto dell’enorme notorietà il termine è relativamente moderno.
Il primo vocabolario del dialetto siciliano che si occupa di mafia è quello di Antonino Traina che così recita: “Neologismo per indicare azioni, parole o altro di chi vuol fare il bravo: sbraceria, braveria // Sicurtà d’animo, apparente ardire: baldanza // Atto o detto di persona che vuol mostrare più di quel che è: pottata// Insolenza, arroganza: tracotanza// Alterigia, fasto: spocchia// Nome collettivo di tutti i mafiosi (smaferi si chiamano in Toscana gli sgherri; e maffia dicon alla miseria, e miseria vera è credersi grand’uomo per la sola forza bruta! Ciò che mostra invece gran brutalità, cioè l’essere grande bestia!)”.
Prima del 1868, anno di pubblicazione del vocabolario del Traina, assolutamente niente, né nel vocabolario siciliano etimologico dell’abate Michele Pasqualino (Reale Stamperia Palermo 1785) dove si trova solo il termine mafuiè (ischerzo per cosa di vil condizione), né nelle prime due edizioni del Nuovo dizionario di Vincenzo Mortillaro Marchese di Villarena (Pietro Pensante Palermo 1838 – 1853), né nel Dizionario del Biundi (Palermo 1857).
Si dovrà aspettare la terza edizione del Mortillaro del 1876 per ritrovare il termine ma con una definizione eccessivamente striminzita e sicuramente apologetica sulle origini: “Voce piemontese introdotta nel resto d’Italia ch’equivale a camorra”.
Da queste prime apparizioni si nota chiaramente uno spaesamento dei linguisti siciliani e una certa confusione, alimentata da altri studiosi, più o meno moderni, che vogliono il lemma di derivazione araba.
Ad eccezione del filone arabo, che appare l’unico scevro da condizionamenti apologetici, culturali e politici, e comunque confutato da Santi Correnti che afferma che nessuno in Sicilia nella seconda metà dell’Ottocento utilizzava la lingua araba, degli altri tre (piemontese, toscano, siciliano), quello toscano, a nostro parere, appare il più logico. Traina, infatti, constatando la quasi totale corrispondenza tra “mafia” e “maffia” e ponendo l’origine dei comportamenti mafiosi in relazione con la miseria, fa un’operazione, magari semplicistica, ma certamente la meno pervasa di sicilianismo (cioè la difesa tout court dell’onore dei siciliani dai nuovi invasori sabaudi).
Se l’etimologia presenta parecchi interrogativi, chiarissimo, invece, è il modo con cui il termine si diffonde in Sicilia, in Italia, in Europa. Nel 1863 viene messa in scena l’opera teatrale I mafiusi di la Vicaria (storico carcere di Palermo trasformato nel 1842 in Palazzo delle Reali Finanze a seguito del trasferimento dei detenuti all’Ucciardone); sulla paternità di questa pièce permane un alone di mistero, come del resto capita spesso quando si parla di mafia. Comunque siano andate le cose, una cosa è certa, il lavoro teatrale ebbe un enorme successo contribuendo alla diffusione del termine con accezione criminale! Recitata in italiano e in siciliano fu tradotta anche nel vernacolo lombardo e napoletano e pare anche in inglese e spagnolo; a Roma e Napoli l’opera fu rappresentata anche di fronte a personaggi illustri, fra i quali Umberto I futuro re d’Italia.
Nella commedia la parola <mafiosi> compare una sola volta, appunto nel titolo e <mafia> non compare mai. D’altro canto, fu in seguito al grande successo di I mafiusi di la Vicaria che si cominciò ad usare la parola <mafia> e <mafioso> per designare criminali che sembravano comportarsi in modo simile ai suoi personaggi.
Se dal punto di vista etimologico regna il mistero, non va certo meglio dalla prospettiva semantica, anzi la confusione si amplifica con il risultato di definizioni parziali, dettate spesso da congiunture storiche, da intenzioni apologetiche, che hanno alimentato e ancora oggi alimentano infinite polemiche a tutti i livelli, da quello politico a quello giornalistico e giudiziario, negli studi di storici, sociologi, economisti, antropologi. Ognuno ha voluto sottolineare un aspetto piuttosto che un altro rendendo il termine un ideale contenitore di definizioni più o meno probabili.
Con molta probabilità, la prima volta che il termine appare in un vocabolario della lingua italiana è databile al 1877, in quell’anno edito da Paolo Carrara, Milano viene stampato “Il lessico della corrotta italianità” di Pietro Fanfani e Costantino Arlia che alla voce mafia recita:“Voce del dialetto siciliano passata oramai sventuratamente nella lingua comune per additare una combriccola di gente, la quale con le minacce e, occorrendo con la forza s’impone a tutti e per tutto”. Qualche anno più tardi lo stesso Fanfani corregge il tiro (Giuseppe Rigutini, Pietro Fanfani, Vocabolario italiano della lingua parlata, Barbera, Firenze 1893): “Nome di un’associazione segreta in Sicilia che ha per fine il vantaggio dei propri aderenti conseguito con mezzi illeciti”.
Nessuna traccia nel vocabolario degli accademici della crusca in tutte e cinque le sue edizioni, l’ultima delle quali, redatta dal 1863 al 1923, poteva benissimo contenerla e neanche nel Tommaseo-Bellini del 1869 dove è presente l’accezione toscana maffia che, come abbiamo già constatato, significa miseria.
Ma lasciamo le definizioni di vocabolari e dizionari e veniamo a quello che sulla mafia è stato detto e scritto da uomini delle istituzioni o della cultura.
Risale al 1828 la prima notizia in cui si parla di una associazione di tipo malandrinesco non ancora definita mafia. Il Procuratore Generale di Girgenti (l’odierna Agrigento), facendo propria una denuncia del giudice di Cattolica Eraclea riferì ai propri superiori di una “organizzazione di oltre 100 membri, di diverso rango, i quali erano riuniti in fermo giuramento di non rivelare mai la menoma (minima) circostanza delle loro operazioni a costo della vita, e che conservavano a difesa comune una somma considerevole di denaro in cassa”. L’organizzazione era diffusa in più comuni dell’agrigentino ed era retta da rituali.
Assai più interessante è la denuncia che il 3 agosto 1838 fece Pietro Calà Ulloa, Procuratore Generale della gran corte criminale di Trapani; ancora una volta non si parla esplicitamente di mafia ma la descrizione che si fa del fenomeno, in un periodo che potremmo definire di incubazione, è sorprendente e risulta estremamente familiare alla luce di quanto oggi sappiamo sull’organizzazione.
Il 25 aprile 1865 può essere, a buon diritto, considerata una data storica, infatti il termine “maffia” compare per la prima volta in un documento ufficiale. E’ la data che appare in un rapporto del prefetto di Palermo, il marchese Filippo Antonio Gualtiero, inviato al ministro degli interni del governo italiano. Il prefetto è di origine toscana (Orvieto 6 agosto 1819) e credo che proprio per questo usa la parola maffia con due f.
Il prefetto si mostra parecchio allarmato ed è sicuramente fra i primi ad intuire il rapporto tra la mafia e la politica. Non era dunque criminalità comune o brigantaggio, ma una criminalità particolare in simbiotico rapporto con i più svariati partiti politici che mettendo insieme violenza e politica aveva come obiettivo il rovesciamento del neonato regime monarchico costituzionale. La mafia era già parte integrante della lotta politica, come si vedrà organicamente nel decennio successivo, lo sbaglio del prefetto fu quello di affermare, senza alcun dubbio, che i cattivi fossero tutti da una sola parte dello scacchiere politico, quello dei partiti di opposizione.
E veniamo al fatidico triennio 1874-1876 durante il quale, come afferma John Dickie, la mafia fa il suo ingresso trionfale nel sistema italiano, determinando la sottovalutazione e di fatto il disinteresse della classe politica nei confronti del problema.
Fin dal 1860 il neonato stato unitario era stato governato dalla cosiddetta Destra storica. Nelle elezioni politiche del novembre 1874, pur di strettissima misura, la Destra prevale ancora, ma in Sicilia si verifica un fatto eclatante: ben 40 dei 48 deputati eletti alla camera nei collegi uninominali appartengono all’opposizione, cioè alla Sinistra. “Durante e dopo la campagna elettorale…. La Destra accusò i deputati siciliani della sinistra di voler minare l’unità del paese, di essere corrotti, di utilizzare i banditi per rastrellare voti, di essere mafiosi”. Era il tentativo di rappresentare una situazione nella quale un governo antimafia doveva misurarsi con un’opposizione mafiosa. La scontro politico non si fece attendere e nel giugno del 1875 durante una seduta dei lavori parlamentari i deputati siciliani di opposizione intervennero in sequenza per difendere l’onore dell’isola addirittura negando l’esistenza stessa del fenomeno mafioso. A ristabilire la verità fu l’intervento di Diego Tajani, deputato dell’opposizione ed ex Procuratore generale a Palermo costretto a dare le dimissioni dalla magistratura per il mancato sostegno del governo alle sue indagini, che provavano compromissioni fra la questura e alcuni dei più pericolosi mafiosi di Palermo.
“Egli ammetteva che negare l’esistenza della mafia significava negare il sole, rivelando pagine scandalose sulla collusione tra prefettura, questura e mafia, una politica volta ad insozzare l’anima della Sicilia: complotti inventati dalla questura per reprimere avversari del governo; impiego disinvolto di mafiosi in operazioni di pubblica sicurezza”.
“A questo punto, nessuno poteva ragionevolmente credere che nel Parlamento si fronteggiassero una fazione filomafiosa e una fazione antimafiosa. Per entrambe le parti, la via d’uscita più semplice era lasciar cadere l’intera faccenda. Destra e Sinistra si trovarono d’accordo su quello che è il mezzo prediletto dai politici di tutto il mondo quando si tratta di mettere la sordina a una questione controversa: istituirono una commissione d’inchiesta”.
I commissari presieduti prima da Giuseppe Borsani e successivamente da Romualdo Bonfadini, pur in possesso di una notevole mole di informazioni, provenienti dalle prefetture e questure siciliane che ne davano uno spaccato inquietante “Pervennero a una conclusione che, se non fosse stata architettata per molto serie conseguenze politiche, potrebbe essere oggi riletta come un’esilarante provocazione messa a punto da alcuni buontemponi”. Il fenomeno mafioso venne liquidato come un’accozzaglia di pezzenti, truffatori e fannulloni altro che -strumento di governo locale- come aveva lucidamente affermato Diego Tajani.
Le risultanze della commissione avranno conseguenze devastanti per una reale lotta alla mafia, il termine assumerà sempre più un valore polisemico, il concetto diverrà causa principale di una durissima lotta politica, sociale, culturale tra il nord ed il mezzogiorno. Se da un lato avremo la celeberrima inchiesta di Franchetti e Sonnino che, pur con qualche limite, offre uno spaccato impietoso ma illuminante sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia, sottolineando il rapporto tra la mafia, le attività commerciali e la politica; dall’altro, autorevoli intellettuali siciliani, appiattiti sulle conclusioni della commissione parlamentare, si concentreranno nel descrivere la mafia come qualcosa di bello o grazioso colpevolizzando i settentrionali di aver reso il temine offensivo e criminalizzante. Ci riferiamo soprattutto a Luigi Capuana scrittore, giornalista, critico letterario ma soprattutto fra i più influenti teorici della corrente letteraria del verismo italiano (Verga, De Roberto, Serao, Di Giacomo, Misasi, Deledda, Pascarella, Fucini) e a Giuseppe Pitrè demologo di fama internazionale, accademico della crusca, docente della facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Palermo, nominato senatore del regno nel 1914, autore della Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane pubblicata tra il 1871 ed il 1913 in 25 volumi.
È il trionfo delle tesi socio-antropologiche mediterranee. Si comincia a far strada anche, la nefasta contrapposizione vecchia/nuova mafia, che caratterizzerà le strategie difensive della gran parte dei processi di mafia del XX secolo, fino alle  deposizioni del pentito Tommaso Buscetta (anche lui nostalgico della vecchia mafia, quella tradizionale, quella “buona”), magistralmente decriptate dai giudici Caponnetto, Falcone e Borsellino nel celebre maxiprocesso istruito nel 1986.
deposizioni del pentito Tommaso Buscetta (anche lui nostalgico della vecchia mafia, quella tradizionale, quella “buona”), magistralmente decriptate dai giudici Caponnetto, Falcone e Borsellino nel celebre maxiprocesso istruito nel 1986.
Ancora una volta a fare da cassa di risonanza al mito sulla sicilianità è un’opera teatrale. Il 17 maggio 1890 al teatro Costanzi di Roma va in scena la prima dell’opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga. Il giovane compositore livornese ottiene un successo senza precedenti per una prima operistica, mettendo al servizio di una semplice storia di gelosia, onore e vendetta pagine indimenticabili di musica, come il celeberrimo intermezzo (tra l’ottava e la nona scena) utilizzato da Francis Ford Coppola nel film Il Padrino parte III.
E’ facile concludere che quella descritta da Verga-Mascagni è la Sicilia di Capuana, di Pitrè, di Cutrera…, la Sicilia del mito che l’uomo d’onore o il mafioso non è altro che il frutto del carattere “particolare” dei siciliani.
Grazie anche agli insuccessi dell’azione giudiziaria (si ricordano i processi istruiti sulle indagini del questore Ermanno Sangiorgi, nei cui rapporti il fenomeno mafioso era descritto nei minimi particolari e in cui emergeva chiaramente l’azione di una struttura complessa, gestita da un organo centralizzato, e il processo Notarbartolo prima vittima eccellente della mafia) ed al silenzio dei maggiori scrittori siciliani, come Verga e Pirandello, che mai citano la parola mafia nelle loro opere pur descrivendone mirabilmente gli effetti (si veda la novella di Verga La chiave d’oro -1883, o I vecchi e i giovani di Pirandello – 1913), la tensione sul problema mafia si affievolisce enormemente consentendo il consolidamento del fenomeno, in organico rapporto con il potere politico.
Anche la magistratura ha le sue responsabilità. Per molto tempo, soprattutto quella siciliana, ha garantito la pressoché totale impunità della mafia, avvertendola non come un pericolo o un’attività illegale, ma sottolineandone l’utilità nella lotta a quei delinquenti, a quei banditi, a quei criminali che invece, loro sì, erano contro le istituzioni.
Non meno responsabilità ha avuto la Chiesa Cattolica, soprattutto negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso. Emblematica è la figura del Cardinale Ernesto Ruffini arcivescovo di Palermo dal 1946 al 1967 che, quasi, sembra negare l’esistenza stessa della mafia, e ammesso che esista, afferma, è sicuramente il frutto delle fantasie di sovversivi comunisti. “I mafiosi (ammesso e non concesso che fossero sospettabili di appartenere a una qualche credibile organizzazione) facevano comunque parte del contesto sociale sul quale la Chiesa esercitava ancora (o riteneva di esercitare) la sua antica egemonia. Finché qualcuno di loro non commetteva un vistoso delitto, prevaleva – specie nel giudizio del clero più semplice e sprovveduto – la positiva valutazione della <religiosità> che essi normalmente esibivano in ricorrenti pratiche devozionali……. In definitiva, per un certo clero (ed era purtroppo la maggioranza) esisteva, a volerne riconoscere l’esistenza, una mafia da vedersi come un’espressione quasi <naturale> del tessuto sociale meridionale, delle sue tradizioni specifiche: una <mafia buona>, saggia, persino a volte caritatevole, propizia alla continuità di un sano ordine sociale”.
Nel settembre del 1963 accadde un evento di portata straordinaria, riguardo alle conoscenze sul fenomeno mafioso, che, però, influenzeranno soprattutto il significato della parola mafia. Davanti alla Commissione d’inchiesta del Senato degli Stati Uniti sul crimine organizzato viene chiamato a deporre Joseph Valachi. Il pentito svela per la prima volta, con risvolti mediatici senza precedenti, l’esistenza negli Stati Uniti di una grande organizzazione criminale composta, quasi esclusivamente, da italiani. Per farne parte è necessaria una cerimonia di iniziazione, sottostare a rigidi codici comportamentali, fra cui l’omertà, è organizzata in “famiglie” o “cosche”, ed è retta da una “commissione” centralizzata. Ma la rivelazione più rilevante, ai fini del nostro lavoro, è che tale organizzazione non si chiama mafia ma “cosa nostra” (cioè i nostri affari, la nostra famiglia). Da quel momento la mafia siciliana prende il nome di cosa nostra e il termine viene utilizzato progressivamente per definirla sin dalle origini. Con cosa nostra si intende, quindi, non solo l’organizzazione contemporanea ma anche quella ottocentesca dei latifondisti, dei baroni, dei gabelloti. Emblematico è il titolo del saggio dello storico inglese John Dickie che non è Storia della mafia ma “Cosa nostra – storia della mafia siciliana”.
“Nel momento in cui il mondo conobbe “cosa nostra” il concetto di mafia è stato lasciato alla deriva, in balia delle interpretazioni e delle definizioni più disparate, ed è diventato di fatto un contenitore ideale per racchiudere in sé tutta una serie di improbabili definizioni. Oggi, infatti, tutto quello che ha a che fare con la criminalità organizzata, in generale, è mafia”.
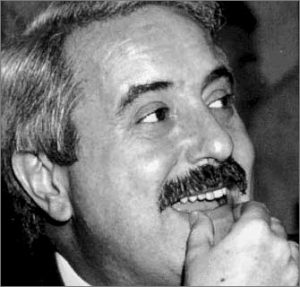 Di questa ulteriore e nefasta tendenza alla polisemia si lamenta il giudice Giovanni Falcone: Mentre prima si aveva ritegno a pronunciare la parola mafia […], adesso si è persino abusato di questo termine […]. Non mi va più bene che si continui a parlare di mafia in termini descrittivi e onnicomprensivi perché si affastellano fenomeni che sono sì di criminalità organizzata ma che con la mafia hanno poco o nulla da spartire. Non si può fare di ogni erba un fascio e chiamare mafia quello che non lo è, altrimenti ci dimostreremo incapaci di elaborare strategie differenziate e le nostre azioni si rivelerebbero meno incisive.
Di questa ulteriore e nefasta tendenza alla polisemia si lamenta il giudice Giovanni Falcone: Mentre prima si aveva ritegno a pronunciare la parola mafia […], adesso si è persino abusato di questo termine […]. Non mi va più bene che si continui a parlare di mafia in termini descrittivi e onnicomprensivi perché si affastellano fenomeni che sono sì di criminalità organizzata ma che con la mafia hanno poco o nulla da spartire. Non si può fare di ogni erba un fascio e chiamare mafia quello che non lo è, altrimenti ci dimostreremo incapaci di elaborare strategie differenziate e le nostre azioni si rivelerebbero meno incisive.
Sembrerà ancora più strano ma il termine mafia entra a far parte del codice penale italiano solo nel 1982, 122 anni dopo l’unità d’Italia. A seguito della strage di via Li Muli dove viene assassinato Pio La Torre il 30 aprile 1982 e della strage di via Carini in cui perde la vita il generale Carlo Alberto dalla Chiesa il 3 settembre dello stesso anno, il Parlamento italiano con la legge 646 del 13/09/1982 (cosiddetta Rognoni-La Torre) introduce nel codice penale il termine mafioso. Accanto all’art. 416 – Associazione per delinquere, appare il 416/bis – Associazioni di tipo mafioso anche straniere; mentre dieci anni più tardi, con la legge 356 del 07/08/1992, verrà introdotto il 416/ter – Scambio elettorale politico mafioso. Per la prima volta nella storia dell’Italia unita lo Stato si attrezza degli strumenti necessari per una seria lotta al fenomeno mafioso.
Alla fine di questo capitolo, in cui più volte mi sono espresso con la frase “per la prima Volta”, desidero soffermarmi su un altro primato e cioè quando “per la prima volta” si parla esplicitamente del fenomeno mafioso in un’opera letteraria. Questo primato spetta ad uno scrittore fra i più amati dai siciliani Leonardo Sciascia. Nel 1961 scrive, infatti, Il giorno della civetta. Mai prima di allora la mafia era stata protagonista di un romanzo; certo una storia di fantasia, ma che attingeva alle esperienze vissute dal giovane insegnante elementare in quella terra dove era nato e vissuto, l’agrigentino. Seguiranno A ciascuno il suo (1966), Il Contesto. Una parodia (1971), Todo modo (1974), Una storia semplice (1989), tutti polizieschi ma, al contrario dei classici gialli, in cui dalla iniziale complicata vicenda si arriva alla soluzione del delitto, nei romanzi di Sciascia tutto si rovescia, anzi il mistero si infittisce.
Infine, mi piace ricordare la definizione che Sciascia diede della mafia nella sua “Storia della mafia” pubblicata come articolo nel 1972 su Storia illustrata, ma già apparsa nel 1957 sulla rivista Tempo presente:
la mafia è una associazione per delinquere,
con fini di illecito arricchimento per i propri associati,
che si pone come intermediazione parassitaria,
e imposta con mezzi di violenza,
tra la proprietà e il lavoro,
tra la produzione e il consumo,
tra il cittadino e lo Stato.

Pingback: 23 maggio, la Giornata della Legalità: le scuole grammichelesi in Piazza Carafa per celebrarla - Grammichele.eu